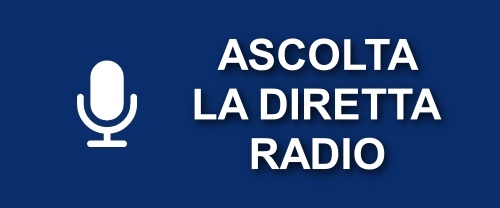La confessione o penitenza è una pratica che consiste nel riconoscimento dei propri peccati e che viene praticata con diverse modalità a seconda della tradizione religiosa.
Nel rito cattolico, il sacramento della confessione viene di norma amministrato da un vescovo o da un presbitero e consente ad un credente, sinceramente pentito, di ottenere da Dio la remissione dei peccati, dopo una profonda riflessione.
Assieme all’unzione degli infermi, viene considerato come uno dei due sacramenti detti “della guarigione”, in quanto entrambi sono volti ad alleviare la sofferenza del credente (sofferenza fisica con l’unzione dell’ammalato, spirituale con la riconciliazione del peccatore).
Storia del sacramento della confessione

La storia del sacramento della confessione ha origini antichissime:nella Chiesa delle origini, se sii commetteva peccati di particolare gravità come idolatria, omicidio e adulterio si veniva immediatamente escluso dalla comunità.
Per un peccatore, tornare ad essere riaccolto nella comunità, richiedeva enormi sacrifici poiché significava ricominciare un percorso iniziatico secondo la quale egli doveva fare a lungo pubblica penitenza per i suoi peccati.
La cosiddetta Penitenza Canonica comportava, infatti, non solo l’essere esclusi dalla comunità ecclesiale, senza poter prendere parte all’Eucaristia, restando a lungo in ginocchio sul nudo pavimento della Chiesa, ma anche i lunghi digiuni e l’obbligo di indossare abbigliamento ruvido e grezzo. Solo al termine del periodo di penitenza, si veniva riaccolti nella comunità dopo un’esortazione del Vescovo e ci si poteva riaccostare all’Eucaristia.
Successivamente la Chiesa modificò la disciplina della penitenza. A partire dal VII secolo, l’iter penitenziale divenne privato e meno gravoso: il peccatore confessava al Presbitero e non più al Vescovo i propri peccati, espiando in privato, e riespiando tante volte quante aveva peccato, così come è in uso ancora oggi.
La Chiesa, inoltre, articolò maggiormente la riflessione sul peccato e cominciò a suddividerlo in categorie, cui venivano assegnate penitenze specifiche. Questo nuovo tipo di penitenza venne detto Penitenza Tariffata, poiché ogni peccato contraeva, in sostanza, un debito verso Dio, che andava pagato secondo una tariffa penitenziale stabilita.
Anche il metodo dei penitenziali, tuttavia, rivelò delle falle. La Riforma Gregoriana dell’XI secolo li soppresse e li sostituì con le “Summae Confessorum“ o “Summae de Paenitentia“, che indicavano più come accogliere ed educare il penitente e quali virtù insegnargli per sconfiggere il peccato che non per quanti giorni dovesse digiunare. Inoltre, le Summae indicavano anche le conseguenze giuridiche di un peccato che, oltre ad offendere Dio, turbava il contesto sociale.
Sebbene le penitenze si fossero molto alleggerite rispetto alle origini, restavano comunque un peso eccessivo per la vita quotidiana dei credenti. Fu introdotta così l’Indulgenza a cui i fedeli tentavano di ricorrervi ogni volta che potevano.
Grazie alla confessione dei peccati e al sincero pentimento, il peccatore doveva affrontare la Pena temporale, che poteva essere cancellata in modo parziale o totale grazie alle Messe, alle preghiere, alle opere di misericordia, alla partecipazioni alle Crociate, ai pellegrinaggi o acquisendo altri meriti.
A partire dal XII secolo si sviluppò la teoria per cui la Chiesa, nel concedere le indulgenze, concedeva ai peccatori la sovrabbondanza dei meriti di Cristo e dei santi, costituenti il tesoro della Chiesa (thesaurus ecclesiae).
Pur nata con l’intenzione di volgere i credenti a penitenze più costruttive, a partire dal 1300 la pratica delle indulgenze provocò una serie di abusi, che andarono oltre i limiti teologici, coinvolgendo ingenti somme di denaro e sminuendo il concetto stesso di Confessione e di Perdono. Numerosi teologi e Santi misero sotto accusa a più riprese il “mercato” delle indulgenze. A seguito di ciò, i promotori del Concilio di Trento (1545- 1563) presero così misure restrittive verso gli abusi delle Indulgenze per ricondurre la pratica, negli anni successivi, a intenti più coerenti con quelli originari.
Con i Concili Ecumenici Vaticano I e Vaticano II, la Chiesa fornì una visione organica del rapporto tra peccato, pentimento, penitenza, riparazione e conversione.
Con l’esortazione apostolica post-sinodale Reconciliatio et paenitentia, del 2 dicembre 1984, papa Giovanni Paolo II precisò la corretta prassi del Sacramento, condannando gli abusi circa la cosiddetta “confessione comunitaria” come mezzo ordinario per confessarsi.
Oggi la religione cattolica definisce il sacramento della confessione anche come sacramento della penitenza, sacramento della conversione, sacramento del perdono e sacramento della riconciliazione. Ognuno dei diversi appellativi fa riferimento alle condizioni che lo rendono possibile (pentimento, confessione) o alle sue conseguenze (perdono, conversione).
Confessione significato
Nella chiesa cattolica, la confessione o sacramento della riconciliazione viene definito come il momento necessario al percorso di conversione, intenso come cambiamento della persona e del suo modo di agire etico.
Tale percorso si articola in quattro fasi:
-
- Pentimento o contrizione: il fedele deve innanzitutto riconoscere i suoi limiti, prendendo coscienza dei peccati che ha compiuto e del fatto di aver intrapreso un percorso sbagliato. Se si pente, conscio di avere offeso Dio, pone rimedio ad ogni suo peccato purché vi sia la ferma intenzione di suggellare questo momento di grazia con il sacramento della confessione.
- Esame di coscienza: è l’atto di riflessione attraverso cui il fedele pentito si interroga sulle cause che l’hanno portato a commettere il peccato. Attraverso l’esame di coscienza il fedele esegue una riflessione sui principi della Fede e sul corretto comportamento che sarà chiamato ad onorare. Questa analisi morale può essere facilitata confrontandosi con un sacerdote che aiuta a comprendere pesi e gravità delle diverse azioni.
- Confessione: è il momento in cui il fedele confessa al sacerdote i suoi peccati a seguito del profondo atto di riflessione. Attraverso la guida del sacerdote, il fedele può comprendere i motivi che l’hanno spinto a commettere i suoi peccati (inesperienza, pressioni sociali, debolezza psicologica ecc..) e ritrovare così la motivazione e la forza per resistere alle tentazioni future. Alla confessione viene attribuito un profondo valore educativo poiché il fedele, dopo aver ricevuto il perdono e la pace, impara a perdonare e non coltivare un atteggiamento ostile, crudele o anche solo inutilmente polemico, costruendo una vera pace quotidiana e la concordia fraterna che lo lega agli altri uomini.
- Soddisfazione: Posto rimedio alle offese compiute, il fedele può andare incontro ad un percorso di cambiamento, un cambiamento di visione e di vita. Il fedele che ha ricevuto la confessione è riconciliato con Dio e può così partecipare all’Eucaristia, consapevole che questo è il fulcro della salvezza e la fonte della forza morale e spirituale che lo renderà capace di non tornare più a commettere i suoi errori.
A cosa serve il sacramento della Confessione
La confessione ha lo scopo di condurre il fedele verso la via della redenzione e della salvezza. Questo percorso dovrebbe portare nel tempo alla nascita di un uomo nuovo, rinnovato e fortificato nel legame stretto con Dio ed i suoi fratelli.
Un sentimento che non deve mancare di rinnovarsi con forza e convinzione nel contesto sociale quotidiano. Il percorso di pentimento e conversione può avere davvero un valore soltanto se i suoi frutti vengono messi in pratica in ogni aspetto sociale della vita: dalla famiglia al lavoro fino ad arrivare al legame con i suoi simili.
Prima Confessione

La prima confessione definisce il momento in cui si confessano per la prima volta i propri peccati di fronte a Gesù Cristo. Prima di ricevere il sacramento della comunione per la prima volta, i bambini vengono guidati verso la comprensione del significato della confessione dalle catechiste oppure dai genitori, che portano con loro ancora il valore dei sacramenti.
Prima confessione spiegata ai bambini
In questo momento particolarmente significativo del percorso cristiano, è importante che il bambino condivida con i propri genitori il cammino che sta percorrendo. La prima confessione è un evento che deve interessare tutta la famiglia. Per aiutare i più piccoli a prendere consapevolezza dei propri doveri cristiani e del profondo significato dei sacramenti, è fondamentale che si instauri un atteggiamento positivo riguardo questo nuovo cammino di redenzione e cambiamento. Per far capire ai bambini la differenza tra scelte ed errori, incidenti e peccati potrebbe essere utile fare dei piccoli esempi riguardanti eventi della vostra vita quotidiana. Le scelte ( giuste o sbagliate) sono azioni che compiamo intenzionalmente.
Gli incidenti e gli errori non sono delle scelte che compiamo intenzionalmente per disobbedire o offendere Dio, di conseguenza non sono peccati. Per far sì che il bambino accolga con consapevolezza la confessione e la comunione, è importante che sappia cosa significa la parola peccato e che sia consapevole che, attraverso il pentimento, è possibile raggiungere il perdono cristiano. É importante inoltre rassicurarlo, facendogli capire che il sacramento del Perdono ha conseguenze meravigliose in chi lo accoglie: la riconciliazione con Dio, con la Chiesa, con i fratelli.
Preparazione alla confessione

Prima di confessarsi è bene riuscire a riconoscere i propri peccati, la loro gravità e le motivazioni che ci hanno portato a commetterli. La fase di preparazione alla confessione è propriamente detta Esame di coscienza proprio perché include una profonda riflessione che parte da un’analisi delle proprie azioni che riguardano i rapporti con il prossimo e con se stessi e culminano nella riflessione sulle cause che le hanno generate.
Guida alla Confessione
L’esame di coscienza però non si riduce ad un mero esercizio di introspezione psicologica perché è una forma di preghiera. E come tale va intesa. Il credente si trova al cospetto di Dio con i suoi peccati e con la richiesta di ricevere una grazia speciale, la grazia di riuscire a vedere le proprie colpe, di riuscire a condannarle e dunque di correggersi. L’esame di coscienza porta il fedele ad esaminare la propria vita, la propria condotta morale, tenendo conto anche dei comandamenti, chiedendo perdono al Signore ogni qual volta ci si rende conto di aver commesso peccato.
Confessione cosa dire
Giunti al momento della confessione, il fedele deve comportarsi come farebbe se si trovasse di fronte a Gesù Cristo, confessando con naturalezza e sincerità i suoi peccati senza tralasciare i peccati veniali (cioè quelli di minor importanza). Durante la confessione, inoltre, il fedele non deve avere timore di confidarsi con il sacerdote in caso lui abbia bisogno di chiedere spiegazioni, chiarimenti o dettagli su quanto raccontato. Non bisogna dimenticarsi, inoltre, che la confessione rappresenta un importante momento di crescita cristiana. In questo momento, il sacerdote è chiamato anche a dispensare consigli utili capaci di aiutare il fedele a ritrovare il cammino verso la redenzione e a resistere così alle tentazioni.
Preghiere dopo la confessione

Al termine della confessione, il sacerdote indica al fedele la penitenza sacramentale da compiere. Quest’ultima consiste in un’opera buona che coincide generalmente nella recita di alcune preghiere che vanno a simboleggiare la volontà del fedele di cambiare vita e di purificare la sua anima dai disordini che l’hanno portato a commettere peccato. Anticamente venivano imposte penitenze molto più onerose ed impegnative. Oggi, invece, la Chiesa resta ad essere molto più mite da questo punto di vista, lasciando alla libertà ed alla coscienza del penitente l’impegno di assumersi eventualmente opere penitenziali più onerose per purificarsi dalle proprie colpe. La penitenza sacramentale che segue la confessione resta ad oggi comunque sempre proporzionale al numero e alla gravità dei peccati commessi.
Atto di dolore confessione
L’atto di dolore o Actus Contritionis è una preghiera cristiana che esprime il dolore per i peccati commessi. Viene, infatti, recitata spesso in occasione del Sacramento della Riconciliazione, dopo l’accusa dei propri peccati e prima dell’assoluzione. Nei libri di preghiera viene indicata non solo tra le preghiere da recitare dopo la confessione, ma anche tra le orazioni da recitare alla sera.
Mio Dio mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati,
perché peccando ho meritato i tuoi castighi,
e molto più perché ho offeso Te,
infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa.
Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più
e di fuggire le occasioni prossime di peccato.
Signore, misericordia, perdonami